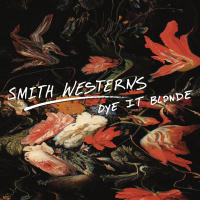 L’adolescenza è il periodo della vita che per eccellenza si presta al ricordo, alla nostalgia, ed è anche la stagione in cui avviene la grande iniziazione alla poetica del rock’n’roll. Per questo non è raro che la musica pop si caratterizzi come ricerca, riscoperta, anche in età più avanzate, di quella sorta di incantesimo, di quella serie di sensazioni, misto di radicale utopismo politico-artistico ed emergente caos ormonale, che connotano quei momenti. Non tanto nei testi, quanto soprattutto in un mood malinconico da cameretta, nell’intuizione che tutto sia possibile e al tempo stesso dietro le spalle, nella chiara percezione di avere qualcosa da dire e nell’altrettanto limpida comprensione di non avere gli strumenti per farlo, si trovano i significanti di quello che non è un genere ma in primo luogo una vocazione: scrivere musica adolescenziale. Non si tratta in effetti di una propensione più o meno dettata da fini commerciali (è l’adolescente, dopo tutto, il principale target di mercato da quando esiste la musica popolare su larga scala), ma probabilmente di uno spirito in qualche modo sempre presente nella scrittura di alcuni artisti, che produce una particolare sintonia con le ansie, le resistenze, le speranze, di alcuni momenti di passaggio legati alla prima età della ragione. D’altra parte ciò esiste anche per altri periodi dell’esistenza: impossibile chiedere ad esempio ai National o ai Black Keys una proposta “giovane”.
L’adolescenza è il periodo della vita che per eccellenza si presta al ricordo, alla nostalgia, ed è anche la stagione in cui avviene la grande iniziazione alla poetica del rock’n’roll. Per questo non è raro che la musica pop si caratterizzi come ricerca, riscoperta, anche in età più avanzate, di quella sorta di incantesimo, di quella serie di sensazioni, misto di radicale utopismo politico-artistico ed emergente caos ormonale, che connotano quei momenti. Non tanto nei testi, quanto soprattutto in un mood malinconico da cameretta, nell’intuizione che tutto sia possibile e al tempo stesso dietro le spalle, nella chiara percezione di avere qualcosa da dire e nell’altrettanto limpida comprensione di non avere gli strumenti per farlo, si trovano i significanti di quello che non è un genere ma in primo luogo una vocazione: scrivere musica adolescenziale. Non si tratta in effetti di una propensione più o meno dettata da fini commerciali (è l’adolescente, dopo tutto, il principale target di mercato da quando esiste la musica popolare su larga scala), ma probabilmente di uno spirito in qualche modo sempre presente nella scrittura di alcuni artisti, che produce una particolare sintonia con le ansie, le resistenze, le speranze, di alcuni momenti di passaggio legati alla prima età della ragione. D’altra parte ciò esiste anche per altri periodi dell’esistenza: impossibile chiedere ad esempio ai National o ai Black Keys una proposta “giovane”.
Gli Smith Westerns da Chicago rappresentano proprio il caso di un gruppo strutturalmente capace di produrre musica adolescenziale: non tanto perché collettivo formato da ragazzi molto giovani, quanto perché titolari di un suono chitarroso, concitato e sognante in grado di adattarsi puntualmente ad un pubblico ed alle sue esigenze che nel tempo, senza eccedere in facili e generici essenzialismi, hanno mantenuto una certa continuità formale. “Dye It Blonde” è il “sophomore album” di questa mobile band che ai membri fondatori Max Kakacek e Cullen Omori, aggiunge il fratello di quest’ultimo Cameron, completando il line up con un batterista variabile: in questo disco Brian Chase degli Yeah Yeah Yeahs e John Eatherly dei Turbo Fruits.
Fin dalle prime battute di “Weekend”, traccia d’apertura disponibile per l’ascolto già da tempo, si notano alcune novità rispetto al primo album omonimo: un suono più uniforme e levigato, una propensione verso un repertorio maggiormente variegato, chitarre tese più alla melodia e meno ad un indistinto rumore di fondo, scelta che nella precedente produzione, oltre ad essere una indiscutibile opzione stilistica, è forse possibile ipotizzare tentasse di mascherare alcune lacune tecniche. Ma le considerazioni di carattere più o meno specialistico lasciano presto spazio al puro divertimento e alla festa prefigurata dal pezzo in questione, perché una cosa è certa: gli Smith Westerns suonano freschi e giovani, evitando nonostante ciò di scadere in retoriche giovaniliste, proprio in ragione di un approccio estremamente personale e naturale al proprio suono. Dopo questa partenza eccellente la prima parte dell’album rallenta non proponendo altre canzoni creatrici di “dipendenza” come il primo pezzo. “Still New” evoca ricordi ormai profondamente sepolti sotto un alone di cinismo e disillusione, ci potrebbe scappare la lacrima se la traccia non suonasse così incredibilmente vitale e cristallina, “Immagine Pt. 3” e “All Die Young” mostrano invece tutto il glam che c’è nei tre dell’Illinois: la prima è la canzone che il Lou Reed dei primi anni ’70 avrebbe voluto veder scrivere al proprio figlio spensierato e immaturo, innamorato della biondina della porta accanto, eccellente a scuola e lontano dalle droghe, in altre parole da un figlio degenere; la seconda è una ballata pianistica e corale, lenta e veloce, divertente e orecchiabile come solo una canzone dei Queen in uno spot del Mulino Bianco sa essere, rendendo così evidente quanti buoni pezzi avrebbero potuto scrivere questi ultimi se solo si fossero pensati un po’ più Beatles e un po’ meno Mozart e Beethoven. “Fallen In Love” chiude l’ideale prima metà con il suo andamento reggae filtrato dai passaggi vocali di un cantato quantomai trasognato.
Ma è dalla sesta canzone che l’album cambia passo e ci consegna alcune piccole perle di scanzonata modestia: “End of the Night” giocando su una chitarra da Beach Boys hardcore descrive geroglifici di delicata nostalgia pop, vibrante di ricordi ed evocativa di un immaginario che recentemente gruppi come i Pains of Being Pure at Heart avevano fatto riemergere, mentre “Only You” investe su un semplice arpeggio alla Peter Buck, riportando la mente ad atmosfere appunto da primi R.E.M., quelli in cui un Michael Stipe brufoloso e capellone girava per l’America cantando liriche tra l’ermetico e l’insensato: non avranno quella qualità e quel roseo futuro davanti, ma gli Smith Westerns, entro ben definiti limiti, possono ambire ad un approdo pop limpido ed ispirato, vero e non retorico, che i quattro di Athens hanno per sempre scolpito nella tradizione della musica americana indipendente e non (andando, sia chiaro, molto molto oltre questo che è solo una minima parte della loro immensa opera). Attraverso un’altra chiara brianwilsonata come “Smile” si giunge alla conclusione con “Dance Away” vero e proprio inno ad un vitalismo individualista e sudaticcio, che si snoda lungo un percorso caratterizzato da alcuni cambi di ritmo degni dei migliori Franz Ferdinand (seppur su una base completamente diversa) e da un ritorno, a tratti, di quel rumore di fondo che aveva connotato il precedente album e che adesso appare più come una scelta oculata piuttosto che una necessità. “Dye the World” sembra infine riassumere, a partire dal titolo, la malinconica freschezza che si percepisce durante l’intero ascolto.
La storia del rock non sarà mai fatta da band come gli Smith Westerns, proprio per i caratteri che rappresentano i loro punti di forza: leggerezza, freschezza, infantile lirismo. Ed è difficile pensarli ad esibirsi in uno dei tanti festival in giro per l’Europa e gli Stati Uniti dopo in calar del sole, quando emergono i grossi calibri. Ad un ascolto superficiale si potrebbe dire che siamo in presenza di una delle numerose band che producono una buona e divertente musica in questo periodo, ma che non hanno la stoffa che altri hanno mostrato, sebbene forse un più elevato grado di originalità, ad esempio i già citati Pains of Being Pure at Heart o i Real Estate. Sicuramente tutto questo è possibile. Ma proprio in virtù di certe qualità, pur non essendo forse altrettanto carismatici e di bella presenza, stupirebbe chi scrive una mancata assunzione entro breve tempo degli Smith Westerns tra le celebrità del rock indie alla moda: l’universo di Strokes, Franz Ferdinand e Arctic Monkeys tra gli altri. La capacità di questi ragazzi del nord degli Stati Uniti di scrivere canzoni piacevoli e di non trascurabile qualità è infatti senza dubbio di quel livello.
(71/100)
(Francesco Marchesi)
6 Febbraio 2011

