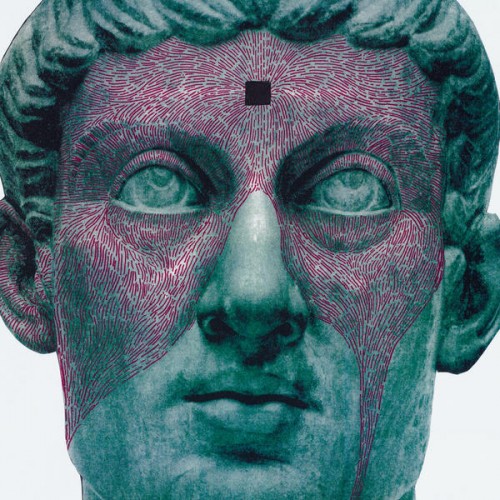Share This Article
Nell’ultimo decennio non si contano i gruppi che, nel bene o nel male, si rifanno a certe sonorità post punk e new wave. Magari alcuni di questi sono anche bravi ma sembra sempre che gli manchi qualcosa. Ecco, i Protomartyr, quartetto americano, hanno questo “quid” in più. Sembrano usciti dalla seconda metà degli anni settanta inglesi, da qualche città industriale schifosa e sporca. E alla fine è così, Detroit – città di provenienza della band – è fortemente indebitata e povera, un luogo senza speranze e prospettive lavorative. Ed è proprio in questa realtà asfissiante che la band fonda le proprie radici: Joe Casey, cantante ed autore di tutti i testi, non è una rockstar maledetta o aspirante tale ma un portiere di teatro che, a trent’anni inoltrati, ha deciso di impiegare il suo tempo libero cantando nella band dei suoi colleghi di lavoro più giovani (Greg Ahee ed Alex Leonard – in origine i Butt Babies). E nel giro di pochi anni- tra il 2012 e il 2015 – il gruppo ha inciso tre dischi: il primo con la Urinal Cake, gli altri due con la Hardly art, sussidiaria della Sub Pop.
“The Agent Intellect”, titolo del terzo album (uscito ad ottobre), è un esplicito riferimento alla teoria aristotelica – discussa nel trattato “De Anima” (quarto secolo a.c.) – de “l’intelletto agente o attivo”: un secondo intelletto, oltre quello “potenziale (possibile o passivo)”, che si libra tra l’anima e il divino e traduce in atto le forme degli oggetti.
Il concetto espresso dal filosofo greco funge, però, solo da ispirazione per la scrittura di Joe Casey. Il (vero) tema centrale del disco è un altro: come funziona la mente umana; e quali meccanismi ci rendono individui singolari ed unici: “tu” sei “tu” ed “io” sono “io”. Due brani in particolare si interrogano su queste due questioni :” Why does it shake?” ed “Ellen”. Entrambi hanno come punto di partenza la madre di Casey, malata di Alzheimer. Il ritornello del primo pezzo, “Why does it shake? / The body/Why does it move?/The fear” si ispira alle parole della donna, che vede le proprie mani tremare. Nel secondo, invece, la narrazione è raccontata dalla prospettiva del padre di Casey , morto qualche anno fa (in “No passion all technicque” (2012) gli è stata dedicata “How he lived after he died”). L’uomo, nel brano, parla alla moglie dall’oltretomba, conserva le memorie di loro due insieme, in attesa dell’arrivo della sua metà : “Beneath the shade/ I will wait/For Ellen/ Though I have gone before/ I will wait/ For Ellen”. Su questo nucleo tematico – “il lavoro della mente” – si inseriscono poi come fotogrammi i racconti per immagini di Casey. La traccia di apertura, “Devil in his youth”, ne è un esempio: la storia di un ragazzo cresciuto e coccolato dal padre in una realtà di provincia e il repentino incattivimento del giovane, una volta venuto a contatto con il mondo reale. La banalità del male in primo piano, quindi, come in “Pontiac 87” : l’incipit cita la visita di Papa Giovanni Paolo II al Silverdrome di Pontiac, nei pressi di Detroit, il 18-19 settembre 1987. Ma Casey non racconta la presunta bellezza e grandezza della cerimonia ma ciò che si nasconde sotto la facciata, dietro l’angolo: i disordini fuori dallo stadio, la brutalità delle persone.
Il culmine della disillusione nelle capacità e possibilità umane si ha però in “Dope Cloud”: canzone sull’impossibilità di essere salvati. Diverse le citazioni: prima di tutto quella del titolo del disco e poi una frase estrapolata dal film “Bernadette” (1943, Henry King): “You dedicated your life to prayer/ You suffered in silence, there”. Anche se il brano parla soprattutto di Detroit, una città, appunto, insalvabile.
Testi forti di grandi impatto, quindi. Ma a fare la differenza vera è l’insieme: l’unione indissolubile tra parole, musica e cantato. La voce di Casey è imperfetta, scoordinata ma proprio per questo motivo suona così sincera, piena di pathos e a tratti, come nel precedente “Under color of official right”(2014), ricorda quella di Mark E. Smith (“I forgive you”, “Boyce or Boice”). È poi fondamentale il suono della sezione ritmica: nel corso dei dischi si è andato ripulendo ma in superficie persistono quelle sfumature, venature di ruvidezza sonora, provenienti da un retroterra garage. Su cui inseriscono riff di chitarra nervosi e taglienti, sorretti in modo violento dalla batteria e che creano l’atmosfera psicotica ed alienata in cui vaga il cantato/parlato di Casey, nevrotico ma che nella penultima traccia, “Ellen”, si apre in maniera inusuale alla melodia.
L’autenticità non è mai il parametro giusto per giudicare un disco. Ma nel caso dei Protomartyr è difficile rimanere impassibili di fronte a una scarica di genuinità così potente e devastante. Post punk targato 2015.
78/100
(Monica Mazzoli)