Share This Article
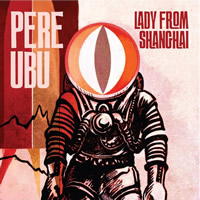 Vi piace Orson Welles? C’è un suo famoso film del 1947 con Rita Hayworth che si chiama “Lady From Shangai”, uno spocchioso noir sopravvalutato, pieno di stereotipi e idealizzazioni da quattro soldi messe in scena con un dispendio di molti più soldi. Il tipico film che uno guarda cercando nella personalità del regista o dell’interprete principale ragioni estetiche sufficienti per potersi distrarre dalla storia. Il disco omonimo dei Pere Ubu ha gli stessi pregi e gli stessi difetti del film di Welles, tutti inevitabilmente riconducibili alla pretestuosità.
Vi piace Orson Welles? C’è un suo famoso film del 1947 con Rita Hayworth che si chiama “Lady From Shangai”, uno spocchioso noir sopravvalutato, pieno di stereotipi e idealizzazioni da quattro soldi messe in scena con un dispendio di molti più soldi. Il tipico film che uno guarda cercando nella personalità del regista o dell’interprete principale ragioni estetiche sufficienti per potersi distrarre dalla storia. Il disco omonimo dei Pere Ubu ha gli stessi pregi e gli stessi difetti del film di Welles, tutti inevitabilmente riconducibili alla pretestuosità.
Il gruppo ha lavorato e speso molto per questo lavoro e ci tiene a farlo sapere, così arricchisce il pacchetto della musica di una cronistoria della produzione che farà felice i fan. Per quanto riguarda la musica, chi ama la band sa cosa aspettarsi e già ha messo in conto tutta l’indulgenza necessaria per un buon ascolto. Chi li conosce poco, o solo di nome, come spesso capita in territorio italiano, farebbe meglio a riprendere “The Modern Dance” del 1978 e quindi “The Art of Walking” del 1980 per capire di che stiamo trattando. Dopo questo studio introduttivo si può affrontare il problema critico, vale a dire capire dove nasce l’amarezza.
Della new wave originale e originaria ormai non ci sono che vestigia, sublimate e deviate in una sorta di post-rock sperimentale, intellettualoide e surreale alla fin fine abbastanza irritante. Questo è il punto. Non basta guardare al tempo e all’età, ai dischi prodotti e alla verve ancora sorridente… queste sono solo attenuanti, non sono reali motivi d’interesse. I Pere Ubu hanno tecnica e visione, sanno giostrare il pathos e conoscono i segreti della meraviglia, sanno essere interessanti, ma non riescono più ad essere importanti, belli.
David Thomas dice di aver pensato e prodotto questo lavoro come fosse un disco dance, e la cosa poteva avere un certo senso, non solo in termini di provocazione, ma di dance o di materialmente ballabile naturalmente c’è pochissimo. Sì, c’è qualche riferimento al funk gelido del Bowie berlinese, qualche concessione elettronica e un po’ di meccanicità che potrebbe assomigliare a incidenza ritmica… ma nulla di più che giustifichi la definizione. La prima traccia del disco “Thanks” è forse la più movimentata dell’album e si struttura infatti come un vecchio brano disco-music passato al vetriolo. Un’invettiva col botto, gravida di ironia e atmosfera. Il resto dell’album procede lungo coordinate di rock sperimentale ed espressionistico ricco di citazioni più o meno sensate. I Pere Ubu vanno a ripescare riff chitarristici da rock tamarro anni ’80, armonie pseudo-pop, dub degenerato alla PiL, neo-retro-proto-punk, e disarmonie concettuali da avanguardia colta.
Ogni tanto s’intuisce una direzione estetica avvincente, un guizzo di genio che pare illuminare la canzone, poi la band trasforma l’intuizione nel suo contrario o si mette a sovrapporre cretinate e tutto finisce nell’inguacchio. “Another One (Oh Maybelline)” è il brano migliore della serie (insieme a “Thanks”), un rock elettronico di grande intensità che rievoca i fasti pseudo garage degli esordi. Carino pure il riff di chitarra di “Lampshade Man”. Tutto il resto suona fintamente isterico, come un’agitazione controllata che lascia il tempo che trova. Vi piace Orson Welles? A me no. Vi piacciono i Rocket From The Tombs? A me sì, sono cento volte meglio di questi Pere Ubu pure che suonavano nel 1975…
55/100
(Giuseppe Franza)
21 gennaio 2013
