Share This Article
Secondo appuntamento per “Linea Nota”, contenitore kalporziano di recensioni di libri musicali libero, trasversale per gusti e generi e soprattutto fruibile. Non solo libri appena usciti o recenti, non solo saggi musicali, ma anche testi di narrativa che abbiano la musica come stella polare del racconto, insomma, in estrema libertà pur sempre musicale.
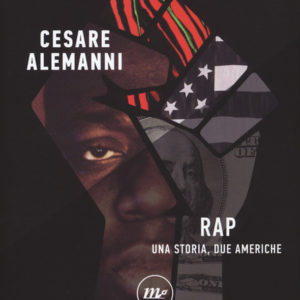 Da ribellione a status quo, da status quo a status symbol. Potrebbe essere questa, in estrema sintesi, la direzione e la traiettoria di un movimento eterogeneo, culturale prima che musicale: il Rap. Cui in aggiunta occorre dare la patente del più influente e contradditorio strumento di emancipazione dell’America nera degli ultimi trent’anni; croce e delizia del mainstream e voce fuori dal coro, più spesso bandiera dello scandalo all’interno di un dibattito (quello sulla condizione della minoranza afroamericana) che negli Stati Uniti dura dalla sua fondazione. Che ogni analisi, disquisizione più o meno informata di cosa voglia dire vivere nella più grande nazione della modernità passi anche, e non solo, dal Rap questo è fuor di dubbio. Tutta la black music non ha fatto altro: legittimare la propria irriducibile identità, in certi casi fotografando una “presenza” in trasformazione nelle relazioni di scambio, in altri, a torto, riducendosi a insieme di valori e idee chiuse a tal punto da produrre ulteriore marginalità.
Da ribellione a status quo, da status quo a status symbol. Potrebbe essere questa, in estrema sintesi, la direzione e la traiettoria di un movimento eterogeneo, culturale prima che musicale: il Rap. Cui in aggiunta occorre dare la patente del più influente e contradditorio strumento di emancipazione dell’America nera degli ultimi trent’anni; croce e delizia del mainstream e voce fuori dal coro, più spesso bandiera dello scandalo all’interno di un dibattito (quello sulla condizione della minoranza afroamericana) che negli Stati Uniti dura dalla sua fondazione. Che ogni analisi, disquisizione più o meno informata di cosa voglia dire vivere nella più grande nazione della modernità passi anche, e non solo, dal Rap questo è fuor di dubbio. Tutta la black music non ha fatto altro: legittimare la propria irriducibile identità, in certi casi fotografando una “presenza” in trasformazione nelle relazioni di scambio, in altri, a torto, riducendosi a insieme di valori e idee chiuse a tal punto da produrre ulteriore marginalità.
Uno strumento prezioso per ripercorrere le tappe di questa rivoluzione è l’ultimo libro di Cesare Alemanni “Rap. Una storia, due Americhe” dove la musica è, finalmente, riconosciuta nel suo valore identificativo, di appartenenza e coscienza collettiva. Una comunità a sé, quella nera, con un problema ancora irrisolto, dove ciascuno vive una doppia condizione, quella di uomo e uomo afroamericano consapevole della sua alterità, i cui comportamenti sono definiti proprio dalla loro extraterritorialità, morale e sociale.
Si tratta di un tipo antropologicamente in conflitto con tutta la sfera del riconoscimento tanto individuale quanto comunitario: lavoro, casa, soldi, rispettabilità, sesso e identità di genere. Questioni apertissime, come si evince dalle cronache che rimbalzano sui media, e trattate da una parte con l’incapacità di rielaborare i nodi sensibili di una controversa e travagliata storia che riguarda noi come Occidente; dall’altra impostando un tipo di racconto, spesso di pura propaganda, completamente distorto spogliato com’è di tutte le implicazioni culturali e politiche di cui si fa sempre più fatica a vedere i contorni. In un dibattito viziato nelle sue premesse, non stupisce che gran parte dell’opinione pubblica disconosca il fenomeno.
La progressione immaginaria da cui siamo partiti iniziava proprio dalla ribellione. Facciamo dunque un salto all’indietro, precisamente a metà anni ’80. Una delle formazioni più intransigenti, nonché musicalmente più prolifiche e innovative, capitanata da Chuck D, passerà alla storia con il nome di Public Enemy. Gruppo insidioso, scomodissimo, che aveva nel mirino delle proprie intemerate alcune delle questioni irrisolte sottese ai rapporti interrazziali negli USA. Polizia, droga schiavismo, istruzione, guerra: nulla sfuggiva all’attenzione della band, composta da soggetti fin troppo consapevoli di alcuni problemi lasciati lì a incancrenire il corpo sociale del ghetto. Uno spazio, quello dei quartieri, che peraltro loro conoscevano da colti e istruiti studenti della Adelphi University di New York. Tra il 1988 e il 1990 compongono due pietre miliari del genere: “It takes a Nation of Millions to Hold us Back” e “Fear of a black Planet”. Entrambi dotati di beat di grande qualità e rime affilatissime saranno l’apice della carriera del gruppo che, anche a causa di problematiche personali e legate all’immagine, affievolirà presto la propria ispirazione, a testimoniare di un’urgenza creativa venuta meno. Ma se qui troviamo la rivolta e la rabbia (un pezzo iconico in tal senso è la loro “Fight The Power”) altrove gli indirizzi sono i più disparati: la goliardia dei Beastie Boys, l’affermazione perentoria e tamarra dei run-DMC, il gigantismo della prima rapstar LL Cool J, la liberazione dei versi in un flow più espressivo ad opera del duo Eric B./Rakim. Tutte queste parabole, singolarmente prese, varrebbe la pena di affrontarle attentamente perché ciascuna rappresenta un segmento necessario a capire l’insieme. Negli anni a seguire, fino ai primi del nuovo millennio, l’industria musicale ormai mastodontica e assoggettata alle leggi implacabili del mercato discografico incoronerà il rap e la cultura hip-hop a idolo cui votare una massa di giovani sempre più omologata e conforme. Da 2Pac a B.I.G, da Jay Z a Dr. Dre, le personalità si fanno ingombranti e la diversificazione di tendenze e gusti diventa infinita.
A picconare il muro delle resistenze residue nei confronti del genere ci penserà Eminem (Marshall Bruce Mathers III): virtuoso, instabile per trascorsi famigliari e incline a sintomi paranoico-depressivi, controverso a dir poco, capace di vendere dischi più di tutti gli altri colleghi, passati e futuri. In poco tempo, il fiume della sua popolarità esonderà ben oltre il pensabile. Un pubblico bianco, il più trasversale, pronto ad accettarne le logiche, si butterà ora e per sempre nelle braccia di una cultura fino a quel momento frequentata con diffidenza e se questo è successo in un tempo così rapido lo si deve al rapper biondo platino, puntuale nella satira dei costumi dello star system (di cui lui ne diventerà stella polare) e durissimo nelle canzoni in cui passava in rassegna il suo privato, costellato di ogni dramma possibile. Il nocciolo indigesto al cuore del successo di questo autore risiede in due elementi, uno funzionale all’altro. Il tramonto del sogno americano e degli USA come soggetto forte nelle dinamiche geopolitiche globali scatenano rabbia e frustrazione, soprattutto presso coloro che quel sogno lo avevano coltivato con più speranza, cioè la maggioranza bianca sempre più impoverita cui viene sottratta l’aspirazione e la speranza: parole magiche del racconto politico. La stessa maggioranza che molti anni dopo eleggerà “il primo presidente bianco d’America”, ovvero Donald Trump, secondo l’efficace espressione di Ta-Nehisi Coates. Eminem si inserisce negli interstizi di questo rancore diffuso per acuirne i suoi gravosi effetti: in molte canzoni i destinatari delle invettive più crude saranno quei soggetti la cui apparizione ha seriamente messo in pericolo la rendita simbolica e materiale del “maschio bianco occidentale”: donne, minoranze, LGBT, immigrati. Amplificatore, non sempre volontario, di tutto l’armamentario ideologico che è alla base di molte rivendicazioni odierne, il rapper di Detroit tenterà di allontanare in ogni modo accuse di xenofobia o peggio di razzismo, tuttavia non riuscendoci appieno. Ancora oggi, senza l’impatto e l’audience di un tempo, Eminem divide e non è detto che questo gli procuri più danni che vantaggi, dati i tempi che corrono.
Si, perché ormai tutto è davvero possibile. Anche che un ex beatmaker di successo, poi autore in prima persona, infine “personaggio” influente come pochi nel mondo dello spettacolo si candidi alle presidenziali americane: parliamo di Kanye West, l’ultimo tassello del nostro mosaico, e sintesi esatta di quello che oggi è diventato il genere. Lunga ormai è la sua carriera di giovane rapper proveniente dall’underground di Chicago, dotato di spregiudicatezza e creatività, attentissimo ai gusti del pubblico sapendolo orientare a propria volta; la discografia di West è quanto di più schizofrenico possa offrire un artista pop di oggi: dal soul all’orchestrale, passando per la cosiddetta black new wave fino ad arrivare ai giorni nostri, saturi di collage a mezzo internet, sovraccarico delle informazioni e scenari post umani. A condensare gli stimoli che da più parti si impongono senza soluzione di continuità realizza quello che ad oggi può essere considerato uno degli album più importanti del terzo millennio, per intensità, puntualità e messa a fuoco. “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, ormai vecchio di dieci anni, chiude un’epoca, musicale e non solo, iniziata con l’abbattimento delle torri gemelle e ora alle prese con altri simboli prossimi allo sgretolamento. In “Runaway” West scrive una lettera d’amore al contrario, cioè a sé stesso, in cui egli si proclama carnefice e vittima ad un tempo, ormai come sprofondato nella spirale del proprio ego, in un abisso buio di rarefatta artificiosità. Potremmo considerarlo l’approdo, e sicuramente non ultimo, di un viaggio lunghissimo che ha condotto il rap a “incarnare una delle principali forme con cui il vuoto edonistico al cuore dell’individualismo collettivo occidentale rappresenta e lamenta sé stesso”, per dirla con le parole dell’autore del libro.
Date le condizioni, con il carico e la gravità della sentenza appena emessa, dobbiamo domandarci se sia ancora così insolita e fuori dalle righe la candidatura di un miliardario profondamente in sintonia con la solitudine di ogni cittadino americano che trae fin dal risveglio motivi sufficienti per giustificare la propria rabbia. La risposta potrebbe essere contenuta nel finale del brano di West appena citato, “Runaway”, il quale con un accumulo sempre più evanescente di acide distorsioni realizza momenti di spettrale e fantasmatica levitazione della musica stessa. Speriamo che il programma elettorale sia più propositivo.
(Alberto Scuderi)
